{{#data.error.root_cause}}
{{/data.error}}
{{^data.error}}
[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}
{{#data.hits.hits}}
{{#_source.featured}}
FEATURED
{{/_source.featured}}
{{#_source.showImage}}
{{#_source.image}}
{{/_source.image}}
{{/_source.showImage}}
{{/data.hits.hits}}
{{{_source.title}}} {{#_source.showPrice}} {{{_source.displayPrice}}} {{/_source.showPrice}}
{{#_source.showLink}} {{/_source.showLink}} {{#_source.showDate}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}: {{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}Avvelenamento da permetrina in un gatto: aspetti clinici e terapia
- Disciplina: Tossicologia
- Specie: Gatto
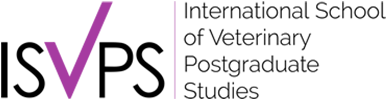
Avvelenamento da permetrina in un gatto: aspetti clinici e terapia (Enrico Bruno, Med Vet, Bologna) La permetrina è una molecola spesso utilizzata nei prodotti ectoparassiticidi spot-on destinati agli animali da compagnia ed è spesso causa di intossicazioni nel gatto. Un gatto di 2,5 anni con anamnesi di applicazione 5 ore prima di un pr
I contenuti di VETPEDIA sono riservati. Effettua LOGIN o REGISTRATI!


